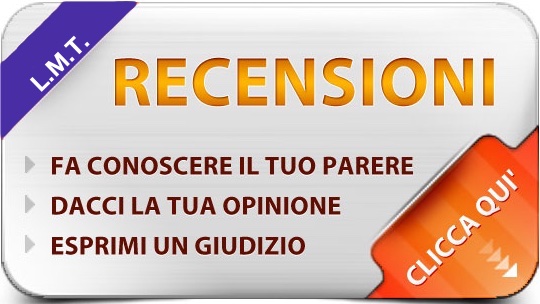Come si arrivati al “biogas fatto bene” e quanto c’è ancora da fare

Articolo è stato pubblicato sul n.2/2018 della rivista bimestrale QualEnergia
Con il settore forestale e agroalimentare l’agricoltura è responsabile complessivamente di oltre il 25% delle emissioni di gas serra a livello globale.
Di conseguenza, nei prossimi anni, dovrà ridurre il proprio impatto sugli ecosistemi e dovrà essere in grado di produrre più derrate alimentari per una popolazione mondiale che verso il 2050 probabilmente stabilizzerà la propria crescita attorno a 10 miliardi di persone.
Anni orsono, in occasione di una crisi dei prezzi petroliferi e di concomitanti annate agrarie tormentate da siccità e calamità naturali nei Paesi esportatori di derrate alimentari, a fronte di un repentino aumento dei prezzi, si diffuse l’allarme sulla possibilità che l’uso di prodotti agricoli a fini energetici potesse mettere a rischio la sicurezza alimentare del pianeta (tra altre, utile la lettura del libro di Lester Brown “Full planet, Empty Plates”).
In tale contesto, iniziarono a circolare i primi scritti dell’avvocato Tim Searchinger, che descrivevano il fenomeno dell’Iluc (Indirect Land Use Change), ovvero gli effetti sull’uso del suolo indotto in modo indiretto dal fatto che i mercati (agricoli) rispondono alla sottrazione di terreno agricolo da usi alimentari per fini energetici in Europa, aumentando la superficie agricola altrove, per esempio in Amazzonia, al fine di mantenere stabili le condizioni commerciali.
In ragione di ciò occorreva attribuire il debito di carbonio dovuto al disboscamento in Brasile non solo agli agricoltori brasiliani di soia o indonesiani di Palm oil, ma anche agli agricoltori europei.
Sulla base di questo assunto, anche i legislatori europei (con il sostegno non casuale di tutti coloro che interessati ad un’economia degli idrocarburi piuttosto che a quella degli idrati di carbonio, o bioeconomia come si dice oggi), hanno attribuito nella legislazione il “debito di carbonio” alle biomasse prodotte su terreni agricoli a causa del loro presunto effetto Iluc. Il mais anche se coltivato con il metodo biologico diveniva quindi più inquinante del gasolio.
Non è qui la sede per dibattere se il teorema Iluc sia fondato o meno: in realtà a noi sembra che contraddica in modo evidente il principio di “chi inquina paga”, sostenuto dal movimento ambientalista sin dai tempi di Rachel Carson.
Poiché in tema di economia le chiacchiere stanno a zero, ben presto i mercati agricoli hanno virato verso una situazione cronica di eccedenza di produzione tipica degli ultimi decenni del secolo scorso, tanto che oggi abbiamo un record storico di cereali nei magazzini e di quantità prodotte.
E conseguentemente i prezzi dei prodotti agricoli sono ritornati a valori reali prossimi a quelli degli anni ’60. Il teorema dell’Iluc, infondato in sé come molte delle teorie malthusiane in tema di scarsità delle risorse, ha avuto il merito di porre due quesiti all’attenzione dei produttori agricoli interessati alla bioenergia:
- che senso ha produrre energia rinnovabile senza una discontinuità con le pratiche agricole attuali, se queste sono, assieme all’utilizzo di idrocarburi, tra le principali cause dell’aumento della concentrazione di gas climalteranti nell’atmosfera?
- Com’è possibile produrre più cibo ed energia trasformando l’agricoltura in una filiera carbon negative e aumentare la sicurezza di approvvigionamento dei mercati alimentari?
Abbiamo avuto la possibilità di formarci un’opinione sul tema dell’Iluc per la prima volta anni orsono ascoltando un dibattito tra l’avvocato Tim Searchinger e il prof. Bruce Dale della Michighan State University: la ragionevolezza delle affermazioni di quel professore è stata strabiliante e convincente.
La successiva lettura del suo articolo “Biofuels Done Right: Land Efficient Animal Feeds Enable Large Environmental and Energy Benefits” ha permesso di comprendere appieno la sua tesi. Ciò che era più convincente era l’idea che in agricoltura si doveva cambiare, non per estensivizzare o demanializzare le pratiche agricole, magari con l’aiuto di contributi “agroambientali”, ma ricercando sistemi agricoli capaci di produrre di più inquinando meno.
Per fare ciò due sembravano le precondizioni: le aziende agricole dovevano diventare più competitive utilizzando di più la potenzialità fotosintetica dei terreni e si doveva offrire loro un modo per diversificare i mercati tradizionali producendo Food and Fuel.
Quando il prof. Dale scriveva pensava alla produzione di etanolo da materiale lignocellulosico, e non certo al biogas.
Ma in quegli stessi anni, a ragione di un incentivo chiaro e della crisi di molti comparti dell’agricoltura italiana, nasceva il biogas agricolo italiano per opera di imprenditori desiderosi di dare una prospettiva alle proprie aziende; realtà oggi divenuta la seconda in Europa dopo quella tedesca.
Ben presto, a quegli agricoltori il tema di quali biomasse utilizzare nei digestori apparve come il tema centrale, soprattutto nelle aree del Paese a elevata densità zootecnica, dove maggiore era il problema degli effluenti zootecnici e dove esisteva un delicato equilibrio per l’approvvigionamento delle filiere zootecniche con insilati.
In Germania, soprattutto in molte regioni dell’Est, le aziende avevano preferito chiudere le stalle e passare alla produzione di biogas. In Italia, Paese del Parmigiano Reggiano e di tanti altri prodotti Dop, una scelta del genere non era neppure lontanamente immaginabile.
Si doveva trovare un’altra soluzione all’uso di mais insilato di primo raccolto o di altre monocolture in generale. In questo contesto nel Cib è nata dieci anni fa una riflessione, riassumibile in una semplice domanda: “con quali biomasse alimentare i digestori utilizzando al meglio il suolo agricolo che con le monocolture veniva lasciato incolto per molti mesi all’anno, anche 13 mesi su 24 in una rotazione mais – soia biennale?”.
Si è così immaginato di estendere la pratica, a volte adottata nelle aziende da vacche da latte, di inserire una coltura di copertura invernale (loietto) prima del mais per la stalla, intensificando così le rotazioni con colture di cereali vernini prima in purezza ora anche in miscuglio.
Le colture invernali si prestavano molto bene per alimentare il digestore, ma, al fine di tesaurizzare le riserve idriche e ottimizzare i tempi di lavoro, si rese ben presto indispensabile apprendere le tecniche di minima lavorazione, di semina su sodo e, più in generale, adottare le pratiche del precision farming anche nell’irrigazione e nella distribuzione del digestato.
Ovviamente questo complicava e non semplificava le attività agricole: era richiesta una maggiore competenza e un’adeguata dotazione di mezzi agricoli.
Ma i risultati spingevano ad andare avanti, anche in assenza di obblighi di legge cogenti, tanto che la ricerca di un’intensificazione sostenibile delle rotazioni colturali non si è limitata alla sola produzione di biomasse per il digestore, ma è stata estesa anche al comparto zootecnico dove alcuni produttori, dopo un orzo insilato per il digestore, hanno iniziato a seminare una soia foraggera insilata che non si vedeva da decenni, come sostituto proteico per la razione delle vacche in lattazione, in sostituzione di quella di provenienza sudamericana.
Le aziende agricole, lungi da una visione autarchica, ma spinte dalle difficoltà di mercato, ricercavano una posizione competitiva perduta non solo grazie ai cash flow derivanti dalla produzione del biogas, ma attraverso una “indipendenza” nell’approvvigionamento energetico, dei fertilizzanti e delle proteine anche nelle produzioni foraggiere.
Ricordiamo lo stupore tra noi agricoltori durante uno dei primi incontri con il management della Fiat sui temi del biometano al Lingotto a Torino quando i tecnici di New Holland ci spiegarono i fondamenti del concetto della “energy indipendent farm”.
Questo percorso è avvenuto sotto le ali protettrici della tariffa incentivante del biogas, che ha permesso agli imprenditori di osare, di sperimentare tecniche nuove, di assumersi dei rischi in una situazione in cui il perdurare della crisi dei prezzi agricoli non permetteva spazi per rischiare alcunché.
Nel frattempo, migliorate le competenze in ambito biotecnologico nella gestione dei digestori, è aumentato l’utilizzo di effluenti zootecnici e sottoprodotti agricoli e agroalimentari, sempre in sostituzione del mais da monocoltura.
Il digestore ha assunto il ruolo di un rumine aggiuntivo perfettamente integrabile nell’azienda agricola, un reattore in grado di produrre energia rinnovabile programmabile, utilizzabile in molte forme e un riciclatore di nutrienti e carbonio organico in azienda rendendo disponibile un fertilizzante organico anche in aziende senza allevamento.
Le rese colturali sono aumentate e l’attenzione si è naturalmente spostata al contenuto in sostanza organica dei terreni che, prima del digestore, da anni, era in costante diminuzione.
Ai soci del Consorzio apparve logico chiamare quest’approccio al biogas agricolo il biogas fatto bene, perché, a parte la filiera tecnologica, si stava mettendo in pratica proprio quanto i ricercatori statunitensi avevano teorizzato; non stava cambiando solo il modo di alimentare i digestori, ma il modo di produrre cereali, ortaggi e foraggi zootecnici nonché il modo di gestire la propria azienda agricola nel suo insieme.
Da allora è nata una stretta collaborazione tra il Cib e il prof. Bruce Dale, il quale, riconoscendo la peculiarità della digestione anaerobica applicata all’agricoltura, ha voluto creare un team di ricercatori internazionali impegnati ad approfondire gli aspetti tecnici e ambientali della filiera.
È nata una buona letteratura sul tema (Valli L. and others “Greenhouse gas emissions of electricity and biomethane produced using the Biogasdoneright system: four case studies from Italy”. Biofuels, Bioprod. Bioref. – 2017).
system: four case studies from Italy”. Biofuels, Bioprod. Bioref. – 2017).
Anche l’associazione europea del biogas, di cui il Cib è socio fondatore, da due anni ha fatto proprio il concetto del biogas done right chiedendo al prof. Dale di aprire il proprio convegno annuale ad Anversa.
Ciò che oggi ci appare molto chiaro è che il digestore costituisce una grande opportunità per trasformare l’azienda agricola in un sistema indipendente da un punto di vista energetico e proteico, potendo quindi ridurre drasticamente l’utilizzo di concimi derivati da idrocarburi e di pesticidi, migliorando il contenuto di carbonio organico del suolo agricolo.
Non solo, le aziende agricole divengono più vitali a ragione del miglioramento del cash flow derivante dalla possibilità di utilizzare in modo flessibile la capacità produttiva del suolo (grazie alla incrementata fotosintesi) per competere in più mercati, alimentari e foraggeri, energetici e in futuro anche dei biomateriali.
Se l’agricoltura biologica è nata come opposizione all’agricoltura convenzionale, cioè a un’agricoltura basata sull’energia fossile e sull’uso di prodotti chimici, l’utilizzo intelligente del digestato nelle nostre aziende è stato un processo spontaneo via via ottimizzato per gli effetti di miglioramento delle rese e della fertilità dei suoli e di riduzione dei costi di concimazione.
Il termine “smaltimento” del digestato è stato presto bandito e la distribuzione in campo, mirata e ottimizzata di questo concime organico, è divenuta il nuovo paradigma.
Oggi le aziende del biogas utilizzano un quantitativo di concimi organici maggiore rispetto ad ogni altra azienda.
Se l’agricoltura conservativa e la precision farming si sono diffuse per opera di alcuni pionieri per andare oltre le tecniche di agricoltura biologica che prevede la lavorazione sistematica dei terreni per il contenimento delle malerbe, in modo analogo nelle aziende del Biogasfattobene il ricorso a questo insieme di tecniche è stato una scelta obbligata per continuare ad alimentare la propria stalla e disporre comunque anche della biomassa da destinare ai digestori.
Quest’approccio pragmatico è certamente alla base del successo della proposta del Biogasfattobene: ha senso economicamente e propone un’immagine dell’imprenditore agricolo come soggetto capace di utilizzare al meglio risorse naturali che solo in parte gli appartengono, come la qualità dell’aria, delle acque e degli ecosistemi rurali.
Questo insieme di pratiche agroecologiche, rese possibili dalla presenza di un digestore nell’azienda agricola, ora non dispone di una specifica codifica o regolamentazione; molte sono le approssimazioni ed è evidente la necessità di arrivare ad una loro sintesi anche formale. Si tratta di un insieme di tecniche:
- capaci di aumentare l’efficienza fotosintetica delle aziende agricole attraverso una intensificazione ecologica delle produzioni, rendendo le aziende capaci di produrre maggiore carbonio biogenico e stoccare più carbonio possibile nel biota e nei suoli agricoli, senza alterare la funzionalità e la qualità degli agroecosistemi;
- in grado di trasformare l’agricoltura da fonte di emissioni di gas climalteranti ovvero di inquinanti in un carbon sink, in altre parole un’agricoltura carbon negative.
È auspicabile che il mondo dell’agricoltura biologica, conservativa e del Biogasfattobene, sappiano dialogare tra loro come in Francia. Siamo appena agli inizi di questa “rivoluzione agricola”. A titolo di esempio pensiamo alle notevoli possibilità di una successiva intensificazione che potrebbe derivare dall’agroforestazione e da un utilizzo del legno in processi termochimici ibridizzabili a quelli di biometanazione nell’ambito del biogas refinery.
Un drastico cambio di marcia è inevitabile: la crisi dei mercati agricoli, la crisi climatica e ambientale richiedono più che mai una rivoluzione. Un’intensificazione ecologica delle produzioni agricole è possibile, anzi, per le aziende agricole italiane è indispensabile.
È auspicabile che nel Paese in cui è nata l’esperienza agro-industriale della Saici di Torviscosa e della Ferruzzi, perduri la volontà di eccellere in quest’ambito mantenendo il pragmatismo dell’approccio sinora adottato dagli agricoltori del biogas fatto bene italiano che, sperimentando senza dogmi e preconcetti, hanno intrapreso una strada cui molti agricoltori anche stranieri si stanno ispirando, pur sapendo che in realtà siamo solo agli inizi e ancora molto resta da fare.
(l’articolo è stato pubblicato sul n.2/2018 della rivista bimestrale con il titolo: “L’agricoltura è precisa”)
Powered by WPeMatico