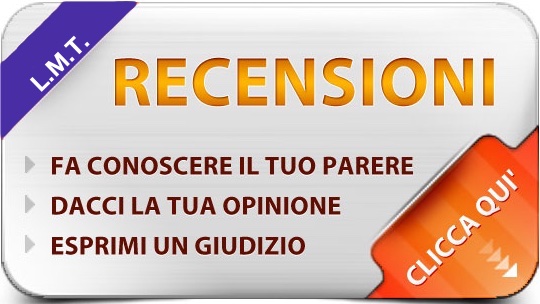Quale approccio per l’accettazione sociale degli impianti a fonti rinnovabili
Non si sa se il nuovo piano per l’energia rinnovabile al 2030, durante il quale l’Italia si dovrà riempire di decine di GW di fotovoltaico, eolico, idroelettrico, biomasse e geotermico, sarà attuabile, a che costi e se arriverà in tempo.
Una cosa però possiamo prevederla con una notevole sicurezza già ora: in parallelo alla sua attuazione, l’Italia si riempirà di “Comitati del No”, che cercheranno di bloccare questa o quella centrale rinnovabile, questa o quella infrastruttura, con ragioni più o meno fondate.
Il problema del rifiuto delle infrastrutture energetiche, verdi o nere o grigie che siano, non è però certo solo italiano, in molti altri paesi occidentali la situazione è simile, e le popolazioni spesso non accolgono con mazzi di fiori iniziative che vanno dal fracking per estrarre idrocarburi fino a nuove linee elettriche o grandi impianti eolici.
Ma non mancano neanche casi opposti, dalla Cina a certe aree degli Stati Uniti, impianti che altrove susciterebbero proteste, vengono accolti senza battere ciglio, se non addirittura con favore.
Hilary Boudet, professoressa di amministrazione pubblica alla Oregon State University, ha cercato, analizzando la vasta letteratura sociologica in materia, di trovare una logica dietro a queste diverse reazioni, per suggerire a politici e imprese le strategie più adatte per evitare di scatenare proteste e comitati inferociti contro gli impianti energetici.
I risultati del suo studio sono stati pubblicati su Nature Energy.
In generale, secondo la ricercatrice, le decisioni pubbliche sull’accettare o meno le infrastrutture energetiche, dipendono da quattro fattori: tecnologia, luogo, persone e processo decisionale.
La tecnologia influisce per i rischi e benefici percepiti, per la sua estetica, per i suoi costi, per lo spazio che occuperà sul territorio.
Il luogo è altrettanto importante: ben diverso aprire un impianto energetico in un deserto o in una zona urbanizzata, dove ce ne sono già tanti o in una zona incontaminata, in un’area ad alta disoccupazione o dove tutti già lavorano.
Le persone possono invece avere un atteggiamento più o meno conciliante a secondo della struttura demografica, dell’accettazione o meno dei benefici dell’industrializzazione, dell’adesione alle politiche governative, dei valori e norme locali, dell’influenza che su di loro esercita l’opinione di esperti o dei contatti sociali.
Infine il processo decisionale influisce a secondo della sua trasparenza, dell’apertura o chiusura al pubblico e di quanti benefici distribuisca e con la scelta dei beneficiari.
«Finora l’approccio per creare consenso intorno a un impianto energetico si è però concentrato su “tecnologia” e “processo”, nel senso di dare molte informazioni sulla tecnologia, offrire qualche modifica per renderla meno impattante e tentare di coinvolgere il pubblico nelle decisioni e offrendo benefits. Ma questo spesso non basta», dice Boudet.
Un punto importante che raramente si considera è che, contrariamente a chi opera in questi settori, l’opinione pubblica di tecnologie energetiche ne sa molto poco: l’energia è una cosa che si dà per scontata, senza preoccuparsi molto da dove arrivi.
«Questa relativa ignoranza, fa sì che quando il pubblico viene improvvisamente coinvolto in decisioni che lo riguardano direttamente, come un impianto vicino a casa, tenda a prendere “scorciatoie cognitive” per decidere quale atteggiamento assumere, che si basano su sentito dire, esperienze proprie o di conoscenti, opinioni politiche, cose lette in rete, pregiudizi o valori di base, non su informazioni obbiettive, complesse da assimilare e magari date da “esperti” sconosciuti, con probabili conflitti di interessi», spiega la ricercatrice.
Contro queste “scorciatoie cognitive”, hanno dimostrato studi sociologici recenti, spesso servono a poco anche le informazioni pubbliche capillari e trasparenti.
«Consultare e informare è certamente indispensabile, ma non sempre fa cambiare idea», sintetizza Boudet. «Per minimizzare il loro effetto, occorre studiare meglio le persone a cui ci si sta per rivolgere e anche i luoghi dove abitano».
Per esempio un’attenta considerazione “sociologica” di dove installare, può essere decisiva.
«Ci sono aree che agli sviluppatori sembrano ideali per motivi tecnici, ma magari alle popolazioni locali sono care per ragioni di tradizione, ambiente o paesaggio, che a loro sfuggono. Informarsi su quali luoghi siano i più amati è importante per evitare rifiuti. Ugualmente puntare su aree dove si vive già grazie a impianti industriali o minerari, rende più facile installarne anche di nuovi energetici».
Oppure, usare un luogo per servirne un altro, per esempio mettere pannelli in campagna per alimentare solo industrie in città, senza particolari benefici locali, per esempio sotto forma di energia scontata che attragga imprese, porta ai “Comitati del No”.
Ancora più importante, però, è capire la comunità in cui si vuole interloquire.
«In generale comunità anziane sono più restie ai progetti su larga scala di rinnovabili di quelle più giovani, gli uomini sono più aperti delle donne, i ricchi più dei poveri, i progressisti più dei conservatori. Si potrebbe pensare che una larga diffusione di idee ambientaliste siano l’ideale, ma come noto queste sono ambivalenti: supportano le rinnovabili in astratto, ma spesso contrastano progetti locali per ragioni di tutela naturale e della salute».
Uno studio sociologico della popolazione locale, quindi, può essere utile per cercare di comunicare con loro in modo efficace, capendo quali siano i loro valori sociali e culturali, e da quali fonti ricavino le informazioni su cui basano le decisioni.
Un bell’esempio di come un’adeguata preparazione sociologica possa aiutare a far accettare tecnologie energetiche molto poco popolari, è quello giapponese: prima degli anni ’70 sembrava proprio l’ultimo luogo dove potesse svilupparsi una filiera nucleare per l’energia, vista l’eredità sanitaria, culturale e psicologica di Hiroshima e Nagasaki.
Eppure, come spiega, lo storico americano John Dower, nel 1973, con l’embargo arabo sul petrolio, il governo giapponese, riuscì a far cambiare la percezione popolare ostile al nucleare, presentando l’alternativa tra “sicurezza personale”, evitando l’installazione delle centrali, o “sicurezza collettiva”, grazie alla maggiore indipendenza che il nucleare offriva al Giappone dalle forniture di petrolio.
Presentata come una sorta di “sacrificio per il benessere nazionale”, il Giappone ha così abbracciato rapidamente la generazione atomica che, prima di Fukushima, è arrivata a fornire un terzo dell’elettricità del paese.
Forse qualcosa di simile bisognerebbe farlo adesso in vista della lotta al cambiamento climatico, costruendo una narrazione collettiva, che metta in contrasto i benefici locali dell’evitare le grandi centrali eoliche, solari, geotermiche o a biomasse, con le conseguenze devastanti per noi e le generazioni future di non fare tutti la nostra parte, anche a costo di qualche sopportabile sacrificio, per bloccare l’avanzata del riscaldamento globale.
«Potrebbe funzionare – conclude Boudet – e sicuramente, in generale, quello che serve è una maggiore comprensione della dimensione umana delle politiche energetiche. Per renderle più sostenibili ed efficaci, bisognerebbe smettere di considerare solo quello che accade nei laboratori di ricerca e nei circoli degli esperti, ma anche cosa si dice e si pensa nelle case, fra vicini, sui social e sui posti di lavoro, nelle comunità su cui ricadranno le conseguenze delle decisioni».
Powered by WPeMatico