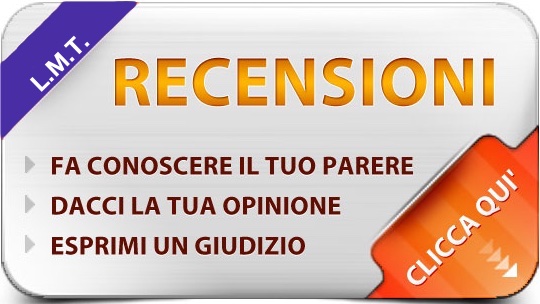Transizione energetica? Ma il denaro è ancora fossile. Il caso Aramco
Quando si parla dei big del settore del fossile che si troverebbero in disarmo difronte all’impetuosa cavalcata delle nuove tecnologie, quella chiamate disruptive, forse è meglio andarci cauti, nonostante alcune fragilità della filiera di petrolio e gas.
Tanto per fare un esempio pochi giorni fa tutta la stampa economica ha sottolineato che Saudi Aramco ha dichiarato che nel 2018 il suo utile è stato pari a 111,1 miliardi di dollari.
Un record assoluto che, giusto per dargli una dimensione, è il doppio di quello di Apple, in seconda posizione a livello globale, e cinque volte di più delle altre due grandi compagnie dell’oro nero, Royal Dutch Shell (23,4 mld $) ed ExxonMobil (20,8 mld $) e ben oltre 23 volte quello di Eni.
Per andare avanti in questo balletto di cifre vale la pena ricordare che la compagnia petrolifera saudita (al 100% di proprietà dello Stato) ha registrato un giro d’affari di 356 mld di dollari, più o meno come il Pil dell’Irlanda.
Aramco nel 2018 è riuscita ad estrarre 10,3 milioni barili al giorno, non arrivando nemmeno alla sua piena capacità di circa 13 milioni, e in più ha estratto ulteriori 3,3 milioni di barili/giorno di altri idrocarburi.
Per capire il peso dei suoi record economici e finanziari dello scorso anno è sufficiente considerare che per estrarre un barile dal sottosuolo ha un costo di appena 2,8 dollari, a cui si dovrebbero aggiungere però altri 4,7 $ per i vari costi degli investimenti. Visto che il prezzo medio del barile WTI nel 2018 è stato sopra i 60 dollari, ecco l’enorme differenza.
La società è stata costretta a presentare il suo bilancio (mai successo dalla nazionalizzazione avvenuta nel 1976), perché ha dovuto collocare obbligazioni sul mercato internazionale per l’acquisto da parte del fondo sovrano saudita del 70% della grande corporation della chimica Sabic, sempre collegata allo Stato saudita. Insomma una sorta di partita di giro.
In totale si tratta di circa 69 mld di dollari, ma già al debutto è riuscita a raccogliere ordini (al momento virtuali) per quasi 100 miliardi di dollari, che è quasi dieci volte il controvalore dell’emissione, poi innalzato da 10 a 12 miliardi di dollari. Anche qui siamo nella sfera dei record di sempre.
Si tratta comunque di un investimento che rientra nella logica di diversificazione degli investimenti sauditi che devono riposizionarsi oltre l’estrazione di petrolio, perché il punto debole del paese (e delle sue aziende pubbliche o parzialmente pubbliche) sta proprio nella quotazione del barile.
Sebbene Aramco riesca a generare oltre 300 milioni di dollari di profitto ogni giorno, una quotazione del barile al di sotto di 45-46 $ avrebbe conseguenze significative sulla solidità del gruppo, così come è accaduto nel 2016, quando tutti gli economics erano più bassi addirittura di 10 volte rispetto al dato record del 2018.
Bisogna capire che questa “fragilità” è legata al fatto che in questi tre decenni la società non ha mai dovuto essere valutata dai mercati finanziari internazionale e, quindi, la sua efficienza, come quelle delle spese per barile prodotto, resta inferiore alle big oil concorrenti.
Infatti dopo ogni barile estratto, nelle casse di Aramco restano circa 26 $, contro i 38 $/barile di cash flow operativo di Shell e i 31 di Total. La ragione: gran parte del denaro è pagato allo Stato in tasse, royalties e dividendi: sono circa 58 mld di $ lo scorso anno. L’Arabia Saudita copre le sue entrate per il 60% proprio dagli introiti degli idrocarburi.
Anche se il dato non è emerso in questa fase di maggiore trasparenza, come alcuni analisti si aspettavano, le riserve di Saudi Aramco sono enormi: ammonterebbero a circa 261,5 miliardi di barili secondo la certificazione indipendente di DeGolyer & MacNaughton, un dato persino superiore alla stima della stessa compagnia saudita.
Sul fronte della diversificazione verso la green energy poco e niente per Aramco, a parte l’obiettivo di ridurre al 2020 del 35% i consumi degli edifici e dei trasporti dell’azienda.
Un po’ quanto accade per le altre del big oil che preferiscono “pompare” mediaticamente le iniziative su risparmi e rinnovabili, ma poi a conti fatti queste costituiscono ancora una parte infinitesimale del loro budget.
La notevole redditività delle compagnie petrolifere è risaputa e per capire che tutto continua a muoversi nella direzione del denaro, anche l’insospettabile Amazon, azienda leader del settore tech tutta rivolta al 100% rinnovabili, ha pensato bene di offrire dei servizi per queste società del fossile, come quello di ridurre i tempi di consegna degli idrocarburi.
Tu quoque, Brute, fili mi, potremmo dire. E allora c’è poco da entusiasmarsi, come sa chi guarda con attenzione i dati climatici sempre più preoccupanti.
Powered by WPeMatico